Anestesia emotiva: che cos’è, quali sono le cause e le soluzioni
L'anestesia emotiva si riferisce alla difficoltà o incapacità di provare emozioni, spesso risultato di traumi o stress prolungato; esplora cause e percorsi di recupero
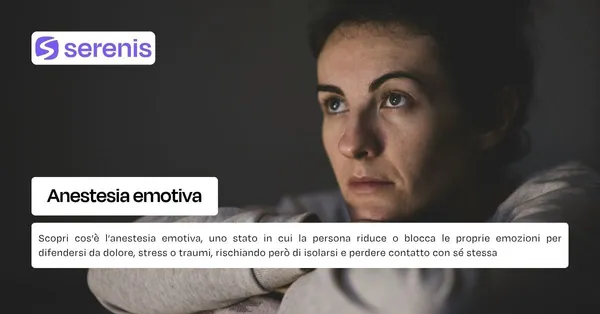
L’anestesia emotiva può essere definita come l’incapacità di entrare in contatto con le proprie emozioni e di esprimerle in maniera corretta.
Si tratta di una condizione che non va confusa con l’apatia (o assenza di emozioni), poiché la persona anestetizzata emotivamente sperimenta forti emozioni: non è però in grado di comprenderle – o si rifiuta di comprenderle – e dunque di elaborarle in maniera corretta.
Parlane con un professionista: ti aiuterà a vederci chiaro.
- Centro medico autorizzato
- 100% professionisti qualificati
- Primo colloquio gratuito
Anestesia emotiva: una definizione
L’anestesia emotiva implica l’incapacità di entrare in contatto con le proprie emozioni e quindi di esprimerle correttamente. Tale incapacità può essere acquisita per ragioni ambientali o motivata da meccanismi di difesa interni al soggetto, che tenta di "mettere a tacere" il proprio universo emotivo per ragioni che analizzeremo in seguito.
L’anestesia emotiva intrattiene un rapporto privilegiato con l’alessitimia, cioè con il mutismo emotivo o letteralmente "incapacità di descrivere ed esprimere le emozioni". Il soggetto alessitimico, non è in grado di riconoscere le emozioni che prova e di conseguenza non sa gestirle in maniera corretta. Con il nostro test sull'alessitimia puoi scoprire il tuo livello di comprensione delle emozioni.
Può allora andare incontro a scoppi emotivi improvvisi, come attacchi di panico o crisi di rabbia. Ricordiamo che l’anestesia emotiva non implica l’incapacità di provare emozioni, ma il tentativo di ignorarle, nasconderle o razionalizzarle attraverso complessi meccanismi di difesa.
Bisogna inoltre tenere a mente la distinzione con l'anedonia, ovvero la ridotta capacità di provare piacere.

Qual è il ruolo delle nostre emozioni?
Le emozioni hanno un ruolo fondamentale nella vita di ogni individuo. Dal punto di vista fisiologico, sono necessarie per elaborare internamente gli stimoli che arrivano dal mondo esterno senza esserne traumatizzati.
Per esempio, la tristezza davanti a un lutto non è solo normale, ma è sana: serve a metterci nella condizione di elaborare l’accaduto senza assumere atteggiamenti dannosi e disfunzionali.
Allo stesso modo, la paura ha una funzione relativa alla conservazione: quando proviamo paura, e fuggiamo da uno stimolo dannoso (come un’aggressione), stiamo utilizzando il meccanismo emotivo per salvarci letteralmente la vita.
Effetti dell’anestesia emotiva
Chi vive una condizione di anestesia emotiva, non riesce ad approcciarsi allo spettro emotivo e ad agire di conseguenza. Può allora sviluppare problematiche di tipo sociale e relazionale, come difficoltà a intrattenere legami duraturi con gli altri.

Può altresì sperimentare sintomi a breve e a lungo termine che comprendono:
- attacchi di panico;
- attacchi di rabbia;
- pianto incontrollato;
- ipertensione;
- mal di testa continui;
- dermatiti o altre problematiche legate alla pelle.
Queste reazioni psicosomatiche sono l’effetto naturale di una "compressione": ignorando o mettendo a tacere le proprie emozioni, il soggetto le vede poi "scoppiare" in maniera imprevista e con enorme violenza sul piano fisico.
A lungo termine, l’anestesia emotiva può portare difficoltà nello sviluppo dell’empatia ma anche dal punto di vista del dialogo interiore. Questo dialogo si trova infatti ad essere privo di riferimenti al vissuto emotivo o alla sfera emozionale in generale.
Così, chi prova anestesia emotiva può arrivare a isolarsi socialmente o a sviluppare relazioni disfunzionali.
Parlane con un professionista: ti aiuterà a vederci chiaro.
- Centro medico autorizzato
- 100% professionisti qualificati
- Primo colloquio gratuito
Come si comporta chi prova anestesia emotiva?
Chi sperimenta questa condizione, spesso soffre di patologie pregresse depressione o disturbi alimentari. In alternativa, potrebbe avere disturbi psicotici e sperimentare derealizzazione e depersonalizzazione.
In psicologia, si possono dividere le emozioni in due grandi categorie: emozioni primarie (cioè quelle che realmente viviamo in rapporto ad un evento) ed emozioni parassite (quelle con cui "copriamo" l’emozione primaria).
Chi vive anestesia emotiva, potrebbe arrivare a coprire le emozioni primarie con emozioni parassite come rabbia, gelosia, invidia e sviluppare comportamenti antisociali pericolosi per se stesso e per il prossimo.

Cause e soluzioni
Tra le cause più comuni di anestesia emotiva, ricordiamo:
- patologie pregresse come depressione, disturbi psicotici, dissociativi o dell’alimentazione;
- vissuti traumatici, che hanno portato il soggetto a staccarsi dallo spettro emotivo per sopportare un evento particolarmente stressante;
- ambiente educativo troppo rigido e violento.
L’anestesia emozionale può essere trattata, attraverso un percorso terapeutico che vada ad individuare la causa della problematica e a risolverla alla radice. Si tratterà, per esempio, di lavorare sul vissuto traumatico che ha innescato la condizione; o, in alternativa, di insegnare all’individuo come rapportarsi alle proprie emozioni, riconoscendole come necessarie ed esprimendole in maniera corretta.
Ricordiamo che l’anestesia emozionale non è considerata una patologia, ma può accompagnarsi ad altre psicopatologie o portare allo sviluppo di reazioni psicosomatiche anche gravi. Se pensi di aver bisogno del supporto di un esperto, Serenis può aiutarti grazie alla psicoterapia online.