Coulrofobia: perché si ha paura dei clown
La coulrofobia è la paura irrazionale dei clown. Chi ne soffre prova ansia, disagio o panico alla vista di clown reali, immagini o anche film. Approfondisci l'argomento e scopri come puoi superare questa paura.
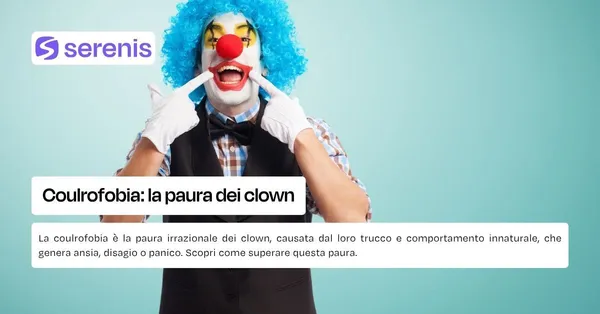
Punti chiave
- Cos'è la coulrofobia: la coulrofobia è una fobia specifica che indica la paura irrazionale dei clown, con reazioni che vanno dal disagio all’attacco di panico.
- Cause: la coulrofobia è legata all’aspetto innaturale dei clown: il trucco marcato, il sorriso fisso e i movimenti strani generano confusione e attivano una risposta di paura.
- Trattamento: si può superare con la psicoterapia, in particolare con tecniche cognitivo-comportamentali, esposizione graduale allo stimolo e strategie di rilassamento.
Cos'è la coulrofobia?
La coulrofobia è la paura irrazionale dei clown. Si tratta di una fobia specifica e chi ne soffre prova disagio, paura intensa o panico alla vista di un clown, anche in immagini o film.
L’origine di questa paura è legata al trucco pesante e alla mimica esagerata dei clown, che rendono difficile leggere le espressioni e le intenzioni. Questo genera insicurezza e allerta nel cervello. Anche i movimenti strani e i vestiti eccentrici possono aumentare il senso di minaccia o imprevedibilità.
Quali sono le cause della coulrofobia?
La coulrofobia ha cause ben precise, legate a come il cervello umano interpreta i volti e i comportamenti.
I clown hanno tratti fisici alterati: il trucco pesante, il sorriso fisso, il naso rosso e le parrucche colorate nascondono le vere espressioni del volto. Questo impedisce alla mente di cogliere le emozioni reali. Quando il cervello non riesce a decifrare uno stimolo, può attivare una risposta di allarme. Anche i movimenti esagerati e innaturali dei clown, insieme agli abiti stravaganti, aumentano il senso di imprevedibilità. Chi soffre di coulrofobia percepisce tutto questo come minaccioso.
Inoltre, i clown sono spesso associati a comportamenti improvvisi o ingannevoli. Il loro ruolo nella cultura popolare – buffi, ma anche irriverenti o caotici – crea un’aspettativa di instabilità e dunque questa incertezza può rafforzare la paura, soprattutto nelle persone più sensibili agli stimoli visivi e comportamentali non coerenti.

Freud e il perturbante
"Il perturbante," secondo Freud, è qualcosa di familiare, ma nello stesso tempo spaventoso. Nella coulrofobia, la figura del clown, pur essendo umana, mostra tratti esagerati che creano una dicotomia tra noto e ignoto, generando ansia e paura.
Nei soggetti coulrofobici, la fobia dei pagliacci ha motivazioni legate al familiare e all’estraneo. In che senso?
- Quando vediamo un clown, siamo sicuri che egli faccia parte della specie umana.
- Al contempo, percepiamo in lui dei tratti difficilmente assimilabili a quelli di un umano - esasperati magari dal trucco o dalla mimica facciale.
- La contrapposizione tra il noto e l’ignoto può scatenare sensazioni di inquietudine e portare allo sviluppo di coulrofobia.
Dopo Freud: l’Uncanny Valley
Per “Uncanny Valley Effect” (traducibile con effetto della zona perturbante) si intende un effetto di inquietudine prodotto da ciò che è insieme familiare ed estraneo.
Questo effetto è alla base di molta ufologia e di figure ideate dal cinema horror e fantascientifico. Quando percepiamo una figura come familiare, e al contempo come estranea, sperimentiamo una profonda sensazione di angoscia e di disgusto.
Lo stesso effetto che possiamo provare di fronte alla figura di un vampiro, sulla medesima base della coulrofobia.
Sintomatologia della coulrofobia
La coulrofobia può presentarsi in forme lievi o gravi, a seconda della persona. In alcuni casi si prova solo disagio o diffidenza verso i clown. In altri, la paura è intensa, irrazionale e accompagnata da sintomi fisici evidenti.
I sintomi più comuni includono:
- Tachicardia (battito accelerato)
- Sudorazione fredda o vampate di calore
- Mal di testa e dolore al petto
- Respiro corto, affanno o senso di soffocamento
- Vertigini, senso di svenimento o “testa vuota”
In caso di esposizione diretta allo stimolo fobico, può scatenarsi un attacco di panico vero e proprio. Chi ne soffre sa che il pericolo è inesistente, ma non riesce a controllare la reazione del corpo.
Se quando vedi un pagliaccio hai questi sintomi e credi di avere la fobia dei clown, puoi parlarne con un terapeuta del nostro centro medico. Potrai condividere le tue preoccupazioni e, se necessario, iniziare un percorso di cura con un terapeuta che ti guiderà in un percorso mirato, aiutandoti a riconoscere la fobia e ad affrontarla passo dopo passo. Il primo colloquio è gratuito, ti basta compilare il nostro questionario.
Parla con un professionista di quello che ti fa paura: l'affronterete insieme.
- 100% professionisti qualificati
- Primo colloquio gratuito
- Centro medico autorizzato
Quando si sviluppa la fobia dei clown?
Le fobie specifiche possono svilupparsi a qualsiasi età. Ciononostante, è noto che la coulrofobia tenda a colpire soprattutto i bambini.
La patologia può poi estendersi fino all’età adulta, con effetti da non sottovalutare sulla vita dell’individuo.
Come superare la fobia dei clown
La coulrofobia può essere trattata con un percorso psicologico mirato. L’obiettivo è ridurre la risposta di paura e aiutare la persona a gestire gli stimoli che provocano ansia.
Un percorso terapeutico come quello cognitivo-comportamentale può modificare la risposta a un certo stimolo e quindi aiutare il paziente a superare la fobia specifica. Ma possono farlo anche:
- la desensibilizzazione sistematica;
- l’EDMR;
- la pratica di esercizi di rilassamento o di mindfulness per placare l’ansia.
In generale, un percorso in studio o online può aiutare il paziente a evitare di assumere atteggiamenti disfunzionali che possano peggiorare il proprio quadro clinico.
Fonti:
- Planting, T., Koopowitz, S. M., & Stein, D. J. (2022). Coulrophobia: An investigation of clinical features. The South African journal of psychiatry : SAJP : the journal of the Society of Psychiatrists of South Africa, 28, 1653.
- van Venrooij, L. T., & Barnhoorn, P. C. (2017). Coulrophobia: how irrational is fear of clowns?. European journal of pediatrics, 176(5), 677.
- Meiri, N., Schnapp, Z., Ankri, A., Nahmias, I., Raviv, A., Sagi, O., Hamad Saied, M., Konopnicki, M., & Pillar, G. (2017). Fear of clowns in hospitalized children: prospective experience. European journal of pediatrics, 176(2), 269–272.