Attaccamento evitante: caratteristiche e conseguenze
Le prime interazioni tra caregiver e bambini modellano profondamente il modo in cui costruiamo relazioni e affrontiamo il mondo. L’attaccamento è un legame essenziale che influenza il nostro sviluppo emotivo e sociale.
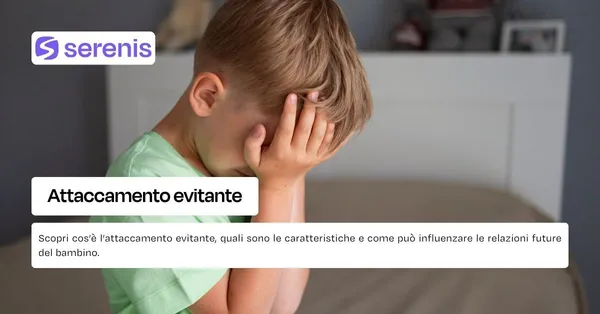
Nell’ambito della psicologia dello sviluppo, una teoria molto discussa è quella dell’attaccamento, secondo la quale le dinamiche che caratterizzano gli scambi che avvengono tra il caregiver e il bambino nei primi mesi e anni di vita si consolidano in veri e propri modelli operativi interni fino a condizionare, in certa misura, le interazioni con gli altri in età adulta.
Tra i vari stili di attaccamento che sono stati individuati esiste anche lo stile di attaccamento evitante.
Cos'è lo stile di attaccamento evitante?
L'attaccamento evitante è uno stile relazionale che si sviluppa nell'infanzia quando un bambino percepisce che i suoi bisogni emotivi vengono ignorati o respinti dal caregiver.
Per via di questi comportamenti del caregiver, il bambino sopprime le proprie emozioni e inizia a contare solo su se stesso per evitare il rischio di essere rifiutato e di conseguenza le emozioni negative come la frustrazione.

Cause dello stile di attaccamento evitante
Tra le cause principali dello stile di attaccamento evitante, ci sono alcuni comportamenti da parte del caregiver che non soddisfano i bisogni del bambino. Tra questi comportamenti possiamo trovare:
- Scarsa disponibilità emotiva: Un caregiver emotivamente distante non risponde in modo adeguato ai bisogni di conforto e vicinanza del bambino. Quando il bambino piange, cerca un abbraccio o manifesta una paura, il caregiver lo ignora, sminuisce la sua emozione o lo punisce.
- Sostegno e incoraggiamento condizionati: il caregiver offre affetto e approvazione solo quando il bambino si comporta in un certo modo, ad esempio quando è "bravo". Per ottenere l'approvazione, il bambino impara a reprimere i suoi bisogni emotivi e a mostrare solo la parte di sé che il caregiver premia.
- Incoraggiamento eccessivo all'indipendenza precoce: in questo caso il caregiver spinge il bambino a essere "forte" e autonomo troppo presto, il messaggio che passa è che la dipendenza emotiva sia qualcosa di negativo. Di conseguenza, il bambino costruisce l'idea che per essere amato e apprezzato deve essere indipendente e autosufficiente.
Per via di questi comportamenti, il bambino si rende conto che i suoi tentativi di avvicinamento emotivo vengono respinti, impara a non cercare più conforto, e sviluppa la convinzione profonda che le relazioni siano pericolose.
Come riconoscere l’attaccamento evitante
A livello sperimentale, esiste un modo per riconoscere con sicurezza l’attaccamento evitante: si tratta del protocollo della Strange Situation, elaborato dalla psicologa Mary Ainsworth negli anni ‘80. Nella procedura vengono messe in scena una serie di situazioni di separazione e ricongiungimento tra mamma e bambino, nel corso delle quali vengono osservate le reazioni del piccolo, specialmente quelle al momento del ritorno della mamma.
In generale, i bambini con attaccamento evitante, abituati a vivere dentro una corazza dalla quale non possono mai uscire emozioni negative, rimangono apparentemente molto calmi quando la mamma se ne va.
Ma la reazione più sconvolgente si ha al rientro del genitore: il bambino con attaccamento sicuro cerca la mamma e la accoglie con calore, mentre il piccolo con attaccamento evitante può ignorare del tutto il genitore o addirittura allontanarlo, preferendo continuare le attività che stava svolgendo.

Attaccamento evitante ed effetti sugli adulti
Ovviamente questo pattern ha delle ripercussioni anche sullo sviluppo della personalità del bambino e, in età adulta, nella modalità in cui si svolgono le interazioni con gli altri.
In particolare, il bambino evitante crescerà nell’insicurezza rispetto alle relazioni: se l’amore è condizionato, non vale la pena investire sugli altri, perché potrebbero sempre abbandonarmi. A livello affettivo, questa modalità che vorrebbe essere protettiva, risulta limitante per gli adulti con attaccamento evitante, perché li spinge a intrattenere relazioni per lo più superficiali.
Queste persone preferiscono preservarsi dalla sofferenza mantenendo sempre un certo distacco dagli altri. In questo modo sono convinti che eviteranno di soffrire, ma agli occhi degli altri appaiono freddi e insensibili, o addirittura incapaci di provare amore, quando in realtà hanno semplicemente eretto intorno a sé un’armatura che li protegga da eventuali rifiuti.
Questo atteggiamento risulta funzionale perché solitamente le persone che da piccole hanno sviluppato un attaccamento evitante hanno una bassa autostima (scopri i nostri consigli sulle letture per chi ha problemi di autostima) e sono convinte che il loro valore sia legato a determinate qualità positive o a quanto sono brave e capaci in qualcosa.
Compila il questionario e scopri quale terapeuta può fare al caso tuo.
- Centro medico autorizzato
- 100% professionisti qualificati
- Primo colloquio gratuito
Attaccamento evitante: che cosa fare?
Se non riesci a intrattenere delle relazioni durature perché fai fatica a fidarti degli altri, hai un blocco nell’esprimere le tue emozioni negative o hai una bassa autostima che a volte ti porta a pensare di non meritare amore, potresti pensare di intraprendere un percorso con un professionista della salute mentale.
Un percorso psicoterapeutico può aiutarti ad esplorare le esperienze passate (magari anche legate all'infanzia) e successivamente ad imparare a riconoscere ed esprimere correttamente le tue emozioni, sviluppando anche delle nuove competenze relazionali.
Il nostro centro medico offre un primo colloquio gratuito con uno dei nostri psicoterapeuti, mentre le sedute successive costano 49 € l'una.
Fonti:
- Rodino, I. S., & Sanders, K. A. (2023). The influence of avoidant attachment and perceived support on disclosure about involvement in donor-assisted conception to family and friends. Human reproduction (Oxford, England), 38(4), 644–654.
- Orehek, E., Vazeou-Nieuwenhuis, A., Quick, E., & Weaverling, G. C. (2017). Attachment and Self-Regulation. Personality & social psychology bulletin, 43(3), 365–380