Overtraining: come uscire dalla dipendenza da allenamento
L’overtraining, o sindrome da sovrallenamento, è uno stato di affaticamento cronico dovuto a esercizi troppo intensi e ravvicinati, che il corpo non riesce a recuperare. Questa guida spiega cosa significa overtraining, i suoi sintomi fisici e psicologici tipici, nonché le cause psicologiche che lo alimentano.
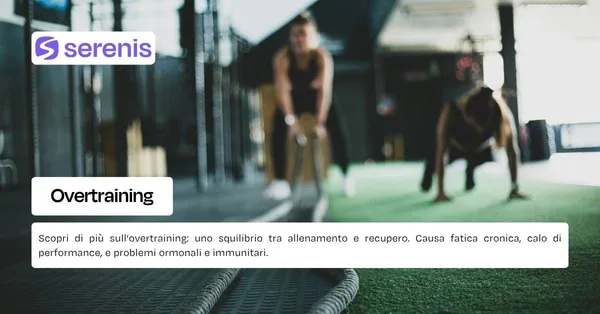
Ti svegli la mattina e la prima cosa che pensi è: "Devo allenarmi", non importa se hai dormito male, se ti senti stanco o se il tuo corpo ti sta mandando segnali di stanchezza. L'allenamento non più un piacere ma è diventato un obbligo. Ti riconosci in questa descrizione?
Se stai leggendo questo articolo, probabilmente hai iniziato a chiederti se il tuo rapporto con l'esercizio fisico sia ancora sano. Forse hai notato che saltare un allenamento ti provoca ansia, che ti alleni anche quando non dovresti, o che, nonostante gli sforzi, i tuoi risultati sono peggiorati anziché migliorati.
Il problema che stai vivendo ha un nome, si chiama overtraining e la buona notizia è che da questa condizione che ti sta facendo male puoi uscirne. Tante persone come te hanno ritrovato un rapporto equilibrato con l'attività fisica, riscoprendo il piacere del movimento senza l'ossessione della performance.
Cos'è l'overtraining?
L'overtraining o sindrome da sovrallenamento, è una condizione che si verifica quando il volume e l'intensità dell'allenamento superano la capacità di recupero del nostro organismo. Questo stato va oltre il semplice eccesso di esercizio, rappresentando uno squilibrio tra allenamento e recupero.
La ricerca scientifica definisce l’overtraining come "uno stato di diminuzione delle prestazioni che persiste per settimane o mesi, accompagnato da disturbi dell'umore e altri sintomi" (Meeusen et al., 2013). Non si tratta semplicemente di essere stanchi dopo un allenamento intenso ma di una condizione cronica che compromette il benessere generale.
A differenza della normale stanchezza post-allenamento, l'overtraining si caratterizza per:
- Prestazioni in costante diminuzione nonostante l'aumento degli sforzi
- Recupero prolungato e inadeguato
- Alterazioni dell'umore persistenti
- Compromissione del sonno e dell'appetito
Il sovrallenamento non è un segno di debolezza o mancanza di motivazione, al contrario, spesso colpisce gli atleti più determinati e appassionati, che, nel loro desiderio di migliorare, finiscono per oltrepassare i limiti fisiologici del corpo.

Effetti dell'overtraining sul corpo
I sintomi fisici sono numerosi e spesso sottovalutati e il sovraccarico muscolare è solo la punta dell'iceberg di una serie di alterazioni che coinvolgono tutto l'organismo.
Iniziamo dai muscoli e dalle articolazioni, i primi a lanciare segnali di allarme. Quando il corpo è in overtraining, i dolori muscolari non scompaiono più con il riposo notturno o i giorni di pausa, sono persistenti e ti accompagnano durante la giornata, trasformandosi, in alcuni casi, in vere e proprie contratture. Al contempo, aumenta drasticamente il rischio di infortuni, il corpo affaticato perde precisione nei movimenti e i muscoli stanchi non riescono più a proteggere articolazioni e tendini. Questa condizione è spesso accompagnata da una rigidità generalizzata che limita i movimenti quotidiani, con crampi muscolari anche durante le attività più semplici.
Anche il cuore non è esente da segni di sofferenza. Secondo una ricerca, l'overtraining può causare alterazioni significative della frequenza cardiaca, evidenziando una frequenza cardiaca a riposo elevata e una variabilità ridotta (Plews et al., 2013). In pratica, il cuore lavora di più anche quando dovrebbe riposare.
Il sistema immunitario, poi, rappresenta un altro fronte critico. Il sovrallenamento, infatti, compromette le nostre difese naturali, rendendo il corpo più vulnerabile a raffreddori, influenze e infezioni alle vie respiratorie. Questo accade perché l'esercizio eccessivo produce un'infiammazione cronica che indebolisce progressivamente l’apparato di difesa. Se ti accorgi di ammalarti più spesso del solito o noti tempi di guarigione più lunghi, potrebbe essere un segnale da non sottovalutare.
Uno degli aspetti più paradossali riguarda il sonno. Nonostante la stanchezza fisica intensa, chi soffre di dipendenza da sport sviluppa disturbi del sonno significativi. Il corpo, mantenuto in uno stato di stress costante, fatica a raggiungere il rilassamento necessario per un riposo profondo e ristoratore. Il risultato è un sonno frammentato, con risvegli notturni frequenti e la sensazione di non aver mai riposato davvero, indipendentemente dalle ore trascorse a letto.
Infine, l'overtraining sconvolge l'intero equilibrio ormonale del nostro organismo. I livelli degli ormoni dello stress come il cortisolo rimangono cronicamente elevati, mentre quelli responsabili del recupero e della crescita muscolare, come il testosterone e l'ormone della crescita, subiscono una drastica riduzione. Anche la tiroide può essere coinvolta, con conseguenti alterazioni del metabolismo. Tutto questo influisce negativamente su energia, umore e capacità di recupero generale.
Parlane con qualcuno che può aiutarti a superarla.
- 100% professionisti qualificati
- Primo colloquio gratuito
- Centro medico autorizzato
Cause psicologiche dell'overtraining
Dietro l'overtraining si nascondono, spesso, dinamiche psicologiche complesse che vanno oltre la semplice passione per lo sport. Comprendere queste cause è fondamentale per affrontare il problema alla radice.
- Molte persone presentano tratti perfezionistici marcati e l'allenamento diventa un modo per mantenere il controllo su almeno un aspetto della vita, specialmente quando altre aree sembrano instabili o insoddisfacenti.
- L'esercizio fisico può diventare il principale strumento attraverso cui la persona costruisce la propria autostima. I risultati fisici e le performance diventano l'unica fonte di valore personale, creando una dipendenza dal successo sportivo.
- La dismorfofobia muscolare, nota anche come vigoressia, può spingere verso l'overtraining. Chi soffre di questa condizione non si vede mai abbastanza forte o definita, indipendentemente dai risultati raggiunti.
- Per molti, l'allenamento intenso diventa un modo per gestire stress, ansia o tristezza. Quando, però, diventa l'unico strumento di regolazione emotiva, può trasformarsi in una trappola.
- La cultura del no pain, no gain e la glorificazione dell'esercizio estremo sui social media possono alimentare comportamenti di overtraining, specialmente nei più giovani.
Effetti psicologici dell'overtraining
L'impatto psicologico dell'overtraining è profondo e spesso più difficile da riconoscere rispetto ai sintomi fisici. La ricerca ha identificato diversi pattern psicologici associati a questa condizione.
Gli studi mostrano che fino all'80% delle persone in overtraining sviluppa sintomi depressivi (Armstrong & VanHeest, 2002). Questo include:
- Umore deflesso persistente
- Perdita di interesse nelle attività quotidiane
- Irritabilità e sbalzi d'umore
- Sensazione di vuoto e apatia
L'ansia legata all'overtraining, poi, si manifesta in diverse forme:
- Ansia anticipatoria prima degli allenamenti
- Panico quando si salta una sessione
- Preoccupazione ossessiva per le performance
- Ansia sociale legata all'immagine corporea
Il sovrallenamento può influire sulle funzioni cognitive, causando:
- Difficoltà di concentrazione e attenzione
- Problemi di memoria a breve termine
- Indecisione e confusione mentale
- Ridotta capacità di problem-solving
Spesso chi soffre di questa condizione inizia a isolarsi socialmente, privilegiando l'allenamento rispetto alle relazioni interpersonali. Ne consegue:
- Perdita di connessioni sociali significative
- Conflitti nelle relazioni di coppia e familiari
- Riduzione delle attività ricreative non legate al fitness

Come uscire dall'overtraining?
Uscire dall'overtraining richiede un approccio graduale e multidisciplinare. Non si tratta semplicemente di smettere di allenarsi, ma di ricostruire un rapporto sano con l'attività fisica e con il proprio corpo.
Il primo ostacolo da superare è ammettere che esiste un problema. Questo può apparire scontato ma per molte persone l'identità è così strettamente legata al loro essere sportivo che riconoscere l'overtraining significa mettere in discussione chi si è. È un momento delicato ma necessario per iniziare il percorso di guarigione.
Contrariamente a quello che potresti pensare, fermarsi completamente non è sempre la soluzione migliore. Gli esperti raccomandano invece una riduzione graduale del volume e dell'intensità dell'allenamento del 50-80% per diverse settimane (Halson & Jeukendrup, 2004). Questo approccio permette un recupero senza uno shock emotivo.
Imparare ad ascoltare il proprio corpo diventa una skill fondamentale. Prestiamo attenzione ai segnali che ci invia ogni giorno: come ci sentiamo al risveglio, qual è la qualità del nostro sonno, se abbiamo dolori o tensioni particolari, come reagisce il nostro cuore all'attività fisica. Tenere un diario può essere utile a identificare pattern e miglioramenti.
L'aspetto nutrizionale gioca un ruolo chiave nel recupero. Spesso, chi è in overtraining, ha sviluppato abitudini alimentari rigide o restrittive e un nutrizionista specializzato può aiutare a ristabilire un rapporto equilibrato con il cibo, assicurando che il corpo riceva il giusto fabbisogno.
Infine, è importante ricordare che l'overtraining raramente è solo una questione fisica. Lo stress generale della vita quotidiana contribuisce significativamente al problema. Per questo motivo, imparare a gestire lo stress attraverso tecniche di rilassamento, una migliore organizzazione del tempo e l'identificazione delle fonti di tensione evitabili può accelerare notevolmente il processo di recupero.
Overtraining e psicoterapia
La psicoterapia rappresenta un elemento fondamentale nel percorso di uscita dall'overtraining, specialmente quando sono presenti componenti psicologiche significative. Un supporto psicologico qualificato può fare la differenza tra una semplice pausa dall'allenamento e un cambiamento duraturo.
La terapia cognitivo-comportamentale si è dimostrata particolarmente efficace perché lavora sui meccanismi mentali che alimentano il comportamento. Attraverso questo approccio, è possibile identificare e modificare i pensieri disfunzionali che spingono verso l'allenamento eccessivo. Il terapeuta aiuta a sviluppare strategie cognitive per gestire l'ansia da prestazione e a costruire un'autostima che non dipende esclusivamente dai risultati fisici.
Affrontare l'overtraining non è un percorso che devi fare da solo. Il supporto psicologico può essere determinante per uscire da questo ciclo e ricostruire un rapporto sano con l'attività fisica e con te stesso.
La terapia online offre un'opportunità unica per chi soffre di sindrome da sovrallenamento. Spesso, infatti, chi vive questa condizione ha difficoltà a ritagliarsi tempo per la cura di sé, essendo completamente assorbito dalla routine di allenamento. La possibilità di seguire sessioni terapeutiche da casa propria, con orari flessibili, può fare la differenza nella scelta di un percorso di cura.
Chiedere aiuto non è un segno di debolezza e l'overtraining è una condizione reale che merita attenzione e cura professionale. Con il giusto supporto, è possibile ritrovare il piacere del movimento e costruire un rapporto più equilibrato con l'esercizio fisico.
Bibliografia
The unknown mechanism of the overtraining syndrome: clues from depression and psychoneuroimmunology. — Sports medicine, 32(3), pp. 185-209
Armstrong, L. E., VanHeest, J. L (2002)
Does overtraining exist? An analysis of overreaching and overtraining research. — Sports medicine, 34(14), pp. 967-981
Halson, S. L., Jeukendrup, A. E. (2004)
Prevention, diagnosis, and treatment of the overtraining syndrome: joint consensus statement of the European College of Sport Science and the American College of Sports Medicine. — Medicine & science in sports & exercise, 45(1), pp. 186-205
Meeusen, R., Duclos, M., Foster, C., Fry, A., Gleeson, M., Nieman, D., American College of Sports Medicine. (2013)
Training adaptation and heart rate variability in elite endurance athletes: opening the door to effective monitoring. — Sports medicine, 43(9), pp. 773-781
Plews, D. J., Laursen, P. B., Stanley, J., Kilding, A. E., Buchheit, M. (2013)